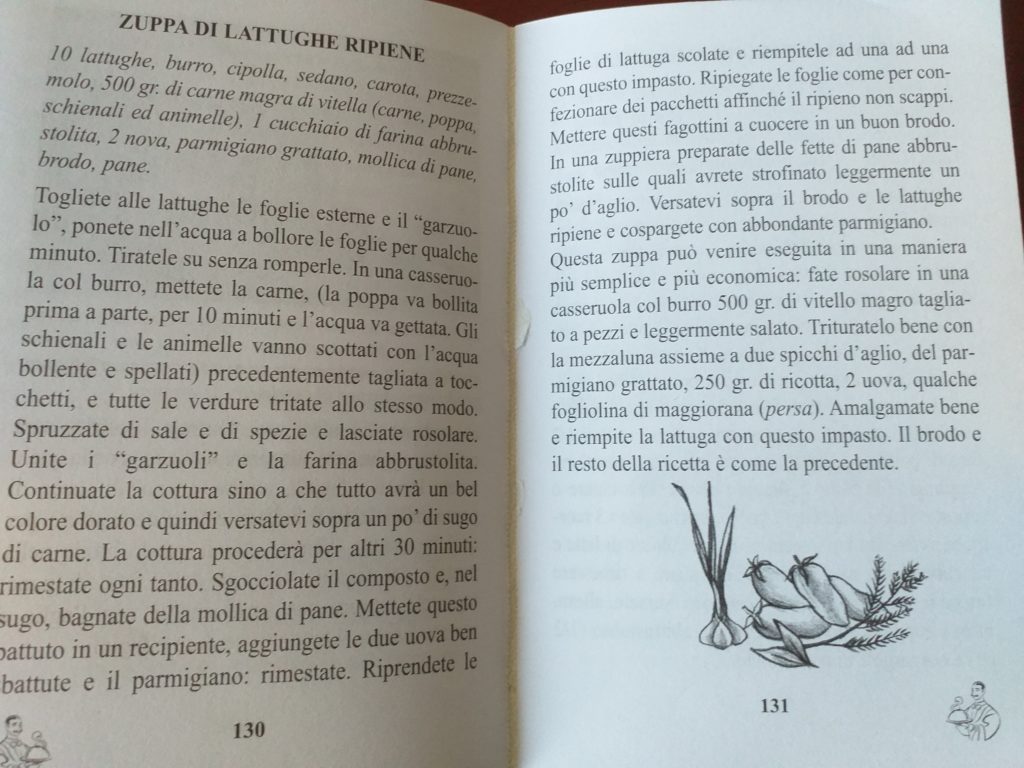Rarissima e minuziosa immagine di Genova nel 1489.
Dettaglio tratto dal Portolano di Albino de Canepa, cittadino genovese attivo alla fine del XV sec.
Da ‘n pòrto à l’atro o dexidëio o l’inscia
veie stramesuæ, bon vento a-o viægio,
e mi do mondo perso, onde m’inäio
con ciù me perdo, con ciù me gh’attreuvo.
De quello che son fæto m’invexendo:
de tutto quello che vorriæ conosce.
Fæta ‘na Zena, ‘nn’atra a l’é ch’a speta
d’ëse fondâ inti seunni e ‘nte memöie.
Lascia che a lontanansa a ne s’ingheugge
indòsso, comme craccia de sarmaxo,
no gh’é destin, no ghe saià retorno,
solo a mäveggia de chi se descreuve.
Da un porto all’altro il desiderio gonfia / vele smisurate, buon vento per il viaggio, // ed io, perso nel mondo, me ne incanto, / più mi ci perdo e più mi ci ritrovo. // Mi esalto per ciò di cui sono fatto, / che è tutto ciò che vorrei conoscere. / Fatta una Genova, un’altra aspetta / di essere fondata nei sogni e nelle memorie. // Lascia che la lontananza ci si attacchi / addosso, come crosta salmastra, / non c’è meta, non ci sarà ritorno, / solo la meraviglia di scoprirsi.
Il viaggio diviene, nei versi del Prof. Fiorenzo Toso liberamente ispirati dall’anonimato genovese, condizione esistenziale e significa conoscenza.
Quell’essere “per lo mondo sì desteixi” è occasione, come argutamente osservato dallo stesso esimio linguista, “di esperienze feconde e manifestazione di creatività, attraverso il mito fondativo di infinite città, non importa se reali, immaginate o ricordate”.