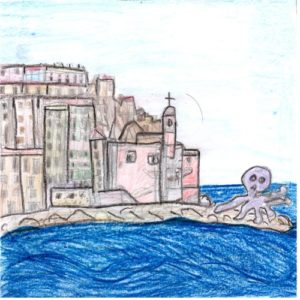Sulle tue montagne, nella ruota
di giovinezza, ho costruito una strada,
in alto fra i castagni;
gli sterratori sollevavano macigni
e stanavano vipere a grappoli.
Era l’estate degli usignoli
Meridiani delle terre bianche,
della foce del fiume Roja.
Scrivevo versi della più oscura
Materia delle cose,
volendo mutare la distruzione,
cercando amore e saggezza
nella solitudine delle tue foglie sole,
e franava la montagna e l’estate.
Anche lungo il mare
Avara in Liguria è la terra,
come misurato è il gesto
di chi nasce sulle pietre
delle sue rive. Ma se Il Ligure
alza una mano,
la muove in segno di giustizia.
Carico della pazienza
di tutto il tempo della sua tristezza.
E sempre il navigatore
spinge lontano il mare
dalle sue case per crescere la terra
al suo passo di figlio delle acque.

Il poeta siciliano futuro premio Nobel per la letteratura nel 1959 s’innamorò perdutamente della Liguria nel 1930 quando, trasferito al Genio civile di Imperia prima e di Genova poi, ebbe modo di conoscere e frequentare Camillo Sbarbaro ed Eugenio Montale, collaborando alla rivista letteraria “Circoli”.
Tre artisti, di cui due premi Nobel e uno Sbarbaro certo non da meno che, da questa terra incrociandosi, trassero feconda ispirazione per influenzare la poesia mondiale del ‘900.

Quasimodo nella sua ultima raccolta ““Dare e avere” 1960 – ‘65” consegna ai posteri una meravigliosa poesia dedicata alla “Liguria”.
In questo componimento il poeta riesce a rievocare l’asprezza della montagna, il sibilo delle vipere, il canto degli usignoli, lo scrosciare delle acque del Roja e, in un continuo crescendo emotivo, l’eterna lotta fra il mare e la terra.
Ma il verso che da sempre mi ha colpito è quel “Ma se il Ligure alza una mano, la muove in segno di giustizia”… e allora sfilano nella mia mente tutte quelle popolazioni liguri che si opposero fieramente all’occupazione della Roma imperiale; i marinai che, sprezzanti del pericolo, difesero le nostre coste dai Turchi e dai Saraceni; i genovesi tutti che, coraggiosi e indomiti, nel 1684 non si piegarono alla boria del Re Sole; il Balilla e la sua audace ribellione contro gli austriaci; i Capitani De Stefanis e Pareto e la loro disperata difesa contro i bersaglieri del La Marmora; Genova intera che nel 1800, oltre ogni umana aspettativa, resistette all’assedio austro piemontese e inglese; i camalli che nel 1924 protestarono contro l’omicidio Matteotti e impedirono alle Camicie Nere l’accesso al porto; i Partigiani che tra l’8 settembre 1943 e l’aprile 1945 contribuirono alla liberazione della Superba, unica caso in Europa nell’era moderna, dai Tedeschi prima dell’ingresso degli alleati; i lavoratori che scioperarono nel giugno 1960 contro la scellerata idea di convocare il congresso nazionale del rinato Partito Fascista in città, contribuendo alla caduta del governo Tambroni.
L’avara Liguria è la mia terra!
Foto di copertina spiaggia di Porto Pidocchio a Framura.