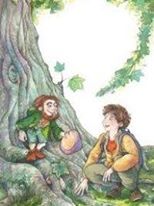tornei… di dita tagliate e occhi strappati.
I Balestrieri genovesi, protagonisti della conquista di Gerusalemme, costituirono il corpo scelto più temuto del Medio Evo.
I Crociati nostrani, insieme a quelli fiamminghi e provenzali, rimasti a guardia del Tempio, diedero origine al secolare ordine dei Templari.

Si esercitavano nella zona del Vastato (o “Guastato”), dove oggi sorge la chiesa dell’Annunziata, partecipavano a veri e propri tornei di selezione banditi in tutta la Repubblica.
Dovevano avere una certa prestanza e soprattutto una notevole mira per utilizzare la “manesca” (nome della balestra genovese) e scagliare i loro dardi fino a quattrocento metri di distanza con precisione assoluta.

La paga era cospicua ma i contratti rinnovati annualmente. Per poter issare lo stendardo di S. Giorgio dovevano salpare almeno cinque galee in assetto da guerra con almeno una “Bandiera” per legno, a bordo.
La “Bandiera” era una formazione di venti balestrieri comandata da un “Conestabile”. I francesi in particolare, ma anche quasi tutti gli altri eserciti europei, li noleggiavano pagando lauti compensi alla Repubblica.
I contingenti potevano raggiungere anche qualche migliaio di individui e, fino all’avvento della polvere da sparo, erano considerati un po’ i “marines” del loro tempo.
Addirittura Federico II, catturatone una formazione nel 1247, fece loro mozzare le dita e orbare gli occhi perché non potessero più nuocere in battaglia.
Il loro utilizzo toccò l’apice durante la Guerra dei Cent’anni a fianco dei francesi e perdurò ancora per gran parte del Cinquecento.
Oggi la Compagnia dei “Balestrieri del Mandraccio” con sede nella Casa del Boia si occupa di mantenerne viva la storia attraverso accurate rievocazioni in costume.