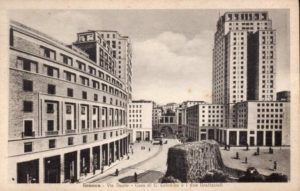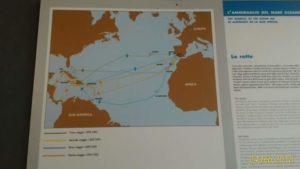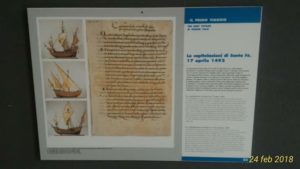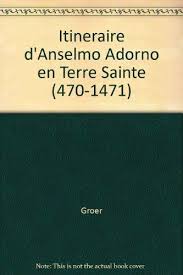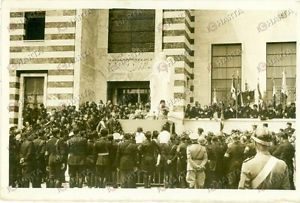“A Cumba” è uno straordinario pezzo in lingua genovese cantato a due voci da Fabrizio De André e Ivano Fossati in cui nenie e usanze riemergono da un passato neanche troppo lontano.
La storia, che racconta di una domanda di matrimonio, si sviluppa in un poetico dialogo fra le aspettative del pretendente e le preoccupazioni del padre…
Gh’aivu ‘na bella cùmba ch’à l’é xeûa foea de cà
gianca cun’à néie ch’à deslengue a cian d’à sâ
Avevo una bella colomba che è volata fuori casa
bianca come la neve che si scioglie a pian del sale
Duv’a l’é duv’a l’é
dov’è dov’è
che l’han vursciua vedde cegâ l’àe a stù casâ
spéita cume l’aigua ch’à derua zû p’ou rià
che l’hanno vista piegare le ali verso questo casale
veloce come l’acqua che precipita dal rio
Nu ghe n’é nu ghe n’é nu ghe n’é
non ce n’è non ce n’è non ce n’è
Padre (F. De André):
Cau ou mè zuenottu ve porta miga na smangiaxun
che se cuscì fise puriesci anàvene ‘n gattixun
Nu ghe n’é nu ghe n’é nu ghe n’é
Caro il mio giovanotto non vi porta mica qualche prurito
che se così fosse potreste andarvene in giro per amorazzi
non ce…
Pretendente (I. Fossati):
Vegnu d’â câ du rattu ch’ou magun ou sliga i pë
Vengo dalla casa del topo che l’angoscia slega i piedi
Padre:
Chi de cumbe d’âtri ne n’é vegnûe nu se n’é posé
Qui di colombe d’altri non ne son venute non se ne son posate
Pretendente:
Vegnu c’ou coeu marottu de ‘na pasciun che nu ghe n’è
Vengo con il cuore malato di una passione che non ha uguali
Padre:
Chi gh’é ‘na cumba gianca ch’â nu l’é â vostra ch’â l’é a me
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’é / nu ghe n’é âtre nu ghe n’é
Qui c’è una colomba bianca che non è la vostra che è la mia
Non ce n’è altre non ce n’è / non ce n’è altre non ce n’è
Coro:
A l’e xëuâ â l’é xëuâ / a cumba gianca
de noette â l’é xëuâ / au cian d’â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d’ou pan.
E’ volata è volata / la colomba bianca
di notte è volata / a pian del sale
La troveranno la troveranno / la colomba bianca
di maggio la troveranno / al pian del pane
Pretendente:
Vui nu vuriesci dàmela sta cumba da maiâ
gianca cum’â neie ch’à deslengue ‘nt où rià
Duv’a l’é duv’a l’é / duv’a l’é duv’a l’é
Voi non vorreste darmela questa colomba da maritare
bianca come la neve che si scioglie nel rio
dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è
Padre:
Mié che sta cumba bella a stà de lungu a barbaciu
che nu m’à posse vèdde à scricchi ‘nte n’âtru niu
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’é / nu ghe n’é âtre nu ghe n’é
Guardate che bella colomba è abituata a cantare in allegria
che io non la debba mai vedere stentare in un altro nido
non ce n’è non ce n’è / non ce n’è non ce n’è
Pretendente:
A tegnio à dindanàse suttà ‘n angiou de melgranâ
cù a cua ch’ou l’ha d’â sèa â man lingèa d’ou bambaxia
Duv’a l’é duv’a l’é / duv’a l’é duv’a l’é
La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni
con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio
dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è
Padre:
Zuenu ch’âei bén parlòu ‘nte sta seian-a de frevâ
Giovane che avete ben parlato in questa sera di febbraio
Pretendente:
A tegnio à dindanàse suttà ‘n angiou de melgranâ
La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni
Padre:
Saèi che sta cumba à mazu a xeuâ d’â më ‘nt â vostra câ
Sappiate che questa colomba a maggio volerà dalla mia nella vostra casa
Pretendente:
Cu ‘â cua ch’ou l’ha d’â sea â mân lingea d’ou bambaxia
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’é / nu ghe n’é âtre nu ghe n’é
Con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio
non ce n’è altre non ce n’è / non ce n’è altre non ce n’è
Coro:
A l’e xëuâ â l’é xëuâ / a cumba gianca
de noette â l’é xëuâ / au cian d’â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d’ou pan.
E’ volata è volata la colomba bianca
di notte è volata a pian del sale
La troveranno la troveranno la colomba bianca
di maggio la troveranno a pian del pane
Duv’a l’é duv’a l’é / ch’â ne s’ascunde
se maia se maia / au cian dou pan
cum’a l’é cum’a l’é / l’é cum’â neie
ch’â ven zu deslenguâ / da où rià.
dov’è dov’è che ci si nasconde
si sposerà si sposerà a pian del pane
Com’è com’è è come la neve
che viene giù sciolta dal rio
A l’e xëuâ â l’é xëuâ / a cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d’â sâ
Duv’a l’é duv’a l’é / ch’â ne s’ascunde
se maia se maia / au cian dou pan
E’ volata è volata la colomba bianca
di maggio la troveranno al pian del sale
dov’è dov’è che ci si nasconde
si sposerà si sposerà al pian del pane
Cùmba cumbétta / beccu de séa
sérva à striggiùn c’ou maiu ‘n giandùn
Martin ou và à pë / cun’ l’aze deré
foegu de légne anime in çé.
Colomba colombina becco di seta
serva a strofinare per terra col marito a zonzo
Martino va a piedi con l’asino dietro
fuoco di legna anime in cielo.
(cit testo completo di “A Cumba” di F. De André e I. Fossati).