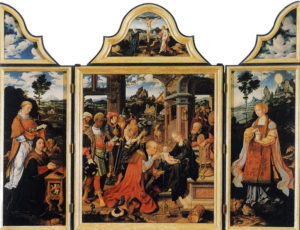La Cattedrale di San Lorenzo non finisce mai di stupire e regala sempre piccole e grandi sorprese. Visto che siamo in tema natalizio ecco che sullo stipite sinistro del portale centrale nel fregio verticale la terza partendo dal basso delle scene rappresenta una splendida Natività del XIV sec.
Gli altri episodi della vita di Gesù descritti sono: l’Annunciazione, la Visitazione, la Natività appunto, l’Epifania, la Presentazione al tempio, la Strage degli Innocenti e la Fuga in Egitto.



La ricerca prosegue all’interno della chiesa, dove s’incontra un imponente gruppo marmoreo bianco di artista ignoto con Bambino, Giuseppe, Maria e pastore in atto di omaggio, noto come la Natività di San Lorenzo.
Imperdibile infine anche il Presepe storico con figure lignee napoletane (XVIII sec.) in abiti finemente addobbati dono del Maestro Mario Porcile (regista e direttore artistico di balletto italiano 1921-2013).



In copertina: il presepe napoletano in San Lorenzo. Foto di Marcello Lusana.